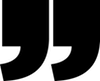L’isolamento nel nord del Québec, come per Martha ad Aupaluk (con 200 abitanti) in Nunavik, è piuttosto comune.
Lei ha 16 anni e la sua migliore amica vive a 80 km di distanza, senza strade di collegamento.
La sua scuola è quasi sempre vuota ma lei ama la tranquillità. Solitamente se ne sta in classe da sola a dipingere usando colori brillanti, sognando il college e pensando a quando anche lei avrà dei bambini. A casa si diletta a cucire parka. Nonostante il freddo arido, Martha cammina lungo la baia ghiacciata.
La primavera è in arrivo.
Diretto da Sarah Baril Gaudet
Montaggio: Justine Gauthier
Produzione: Audrey Fallu
Sound design: Jordan Valiquette
Musica: Wiktor Tyrchan
Consulente creativo: Trystan Millet
Adattamento: Monica Ezekiel, Caroline Oweetaluktuk, Claudia Pisello, Giorgia Frigerio
Intervista

Sarah Baril Gaudet Regista
“Il documentario mi permette
di incontrare persone e mondi
a cui altrimenti non mi sarei mai avvicinata.”
- Raccontaci qualcosa del tuo percorso.
Ho iniziato a interessarmi al cinema e alla fotografia da adolescente. La domenica i miei mi portavano spesso a vedere film del Québec al cinema di Rouyn-Noranda, la città più popolata della mia regione natale, nella parte occidentale del Québec. Poi andavamo a mangiare insieme e parlavamo del film che avevamo visto. Erano momenti molto speciali. Intorno ai quattordici anni ho iniziato a fare dei corti con le mie amiche per dei progetti scolastici. Amavo ogni fase del processo creativo, ma soprattutto le riprese, quando potevo maneggiare la videocamera e scegliere le inquadrature. È a quel punto che ho scoperto il potere evocativo dell’immagine e la sua importanza all’interno della storia.
A diciassette anni mi sono iscritta al corso di arti visive del college, curriculum cinema. Quei due anni hanno confermato il mio desiderio di avere una carriera in ambito cinematografico. Poi sono stata accettata al corso di cinema dell’Université du Québec di Montréal, dove mi sono specializzata nella direzione della fotografia. È lì che ho scoperto un genere che prima conoscevo pochissimo e di cui mi sono subito innamorata: il documentario.
Sono riservata per natura, e il documentario mi permetteva (e continua a permettermi) di incontrare persone e mondi a cui altrimenti non mi sarei mai avvicinata. Come direttrice della fotografia, inoltre, il fatto di lavorare con la realtà, sulla quale abbiamo un controllo limitato, per me rappresentava una sfida stimolante. Alla fine degli studi ho vinto un premio per il mio primo cortometraggio documentario, intitolato È qui che vivo. Il film ha segnato l’inizio della mia giovane carriera da regista.

- Com’è stato girare il film?
Le riprese del cortometraggio sono state costellate di sfide di ogni genere, soprattutto per via del meteo. In inverno le tempeste e le bufere di neve sono molto frequenti nel Nunavik, e possono durare per giorni. Io e il mio team dovevamo prevedere le giornate in funzione delle temperature e stabilire una lista ben precisa delle scene da girare. Non potevamo perdere tempo inutilmente, soprattutto quando si stava preparando una tempesta.
Anche stabilire l’orario delle riprese era difficile, perché ogni giorno dovevamo adattarci alla lentezza della vita degli Inuit. Questo mi sembrava un ostacolo all’inizio, ma alla fine si è rivelato essere un aspetto molto positivo, che ha contribuito ad arricchire il processo di realizzazione del film. Ogni momento passato con Martha, infatti, era prezioso e il montaggio del documentario è stato fortemente ispirato ai ritmi lenti del villaggio. Il tempo passato a Aupaluk mi ha fatto capire fino a che punto il ritmo frenetico delle nostre vite (e di alcune riprese) non abbia alcun senso, e che dovremmo ispirarci allo stile di vita di questa comunità.
Le interviste con Martha, che abbiamo fatto in uno sgabuzzino della scuola (l’unico luogo in cui potevamo registrare con una buona qualità audio), sono state una sfida importante. Per me era essenziale che Martha si esprimesse nella sua lingua madre, l’inuktitut, parte integrante della sua identità. Dato che non parlo la lingua, ho avuto bisogno di un traduttore. Purtroppo qualche ora prima dell’intervista la persona che si occupava della traduzione si è ammalata. Io e il mio team abbiamo quindi deciso di fare comunque l’intervista, chiedendo a Martha di tradurci le risposte in inglese. In seguito abbiamo assunto un’altra traduttrice per la fase di post-produzione del film.
Al di là degli ostacoli, l’esperienza delle riprese nel Nunavik mi ha resa molto più consapevole della vita di questo popolo, e dei suoi giovani, che conoscevo pochissimo. Grazie a È qui che vivo spero di essere riuscita a raccontare una storia che va oltre i pregiudizi e svela un altro lato delle cose, diverso da quello presentato da alcuni media.
“L’uso della focale corta ha dato ai personaggi
la possibilità di esprimersi e di muoversi liberamente in uno spazio ampio.”
- Hai uno stile molto fotografico, con inquadrature lunghe e fisse. Ci dà l’idea che il tempo scorra lentamente intorno a Martha, anche se alla fine del film ci sono piccoli segnali che sembrano annunciare l’arrivo della primavera. Come hai gestito il tempo, il ritmo?
Per me era chiaro che le immagini e il montaggio del film dovevano riflettere il ritmo lento del villaggio. Come direttrice della fotografia ho optato per delle inquadrature lunghe e fisse che permettevano di contemplare la vastità del luogo e i giovani che girovagavano (nelle strade, sui tetti, a scuola). L’uso della focale corta ha dato ai personaggi la possibilità di esprimersi e di muoversi liberamente in uno spazio ampio, permettendomi di catturare più azioni in una singola immagine.
È una scelta che sottolineava anche la solitudine di Martha, che a volte si sentiva persa nell’immensità della tundra. Il paesaggio nordico, austero e maestoso, fungeva da vettore per trasmettere le emozioni della protagonista, e l’uso di inquadrature ampie permetteva di immergersi sia nel luogo che nell’universo intimo di Martha.

- Quale messaggio vuoi trasmettere con questo film?
Attraverso È qui che vivo ho cercato di dipingere un ritratto intimo e sensibile della realtà di una giovane inuit che si pone le stesse domande esistenziali degli altri adolescenti, anche se vive in un territorio isolato. Ho evitato di menzionare alcuni drammi che ha vissuto Martha, perché ritengo che la realtà degli Inuit spesso venga trasposta sullo schermo in modo negativo o tragico. Ero una forestiera, e dovevo quindi osservare Martha e la comunità di Aupaluk con sensibilità e rispetto.
Nel cortometraggio volevo lasciare la parola a questa ragazza, attraverso una serie di brevi riflessioni in cui ci parla della sua quotidianità, dei suoi interessi e delle sue preoccupazioni come voce fuori campo. La mia personale visione della sua realtà e di quella dei giovani era invece rappresentata nel modo in cui filmavo il villaggio e i paesaggi. Insomma, anche se l’universo di Martha è piuttosto diverso dal mio, mi sentivo vicina a lei grazie alla complessa relazione che ha con la sua terra natale. Dato che anch’io provengo da una regione remota, il Témiscamingue, capivo i suoi dilemmi e il modo di trasmetterli sullo schermo.
- Quali progetti hai in programma?
Ho appena finito la post-produzione del mio primo lungometraggio documentario, che si intitola Passage (“Passaggio”). Il film esplora i temi dell’esodo rurale, dell’attaccamento al territorio e della transizione all’età adulta. Nel corso di 81 minuti seguiamo la vita quotidiana di Gabrielle e Yoan durante l’estate dei loro diciotto anni nella regione del Témiscamingue.
Questo primo lungometraggio è molto personale per me, perché esplora il territorio della mia infanzia e adolescenza, attraverso la realtà di due giovani adulti con ambizioni diverse. Se tutto va bene, Passage uscirà prima della fine del 2020, altrimenti nel 2021.

- Qualche parola su 99 e sulla sottotitolazione multilingue del tuo film?
Questa prima collaborazione con 99 è arrivata nel momento perfetto per È qui che vivo, dato che il film ha appena chiuso un bellissimo percorso di due anni di festival. L’adattamento multilingue quindi rappresenta un’ottima opportunità di diffusione per il cortometraggio, che potrà avere nuova vita e raggiungere un nuovo pubblico.
La missione di 99 permette di rendere democratico il documentario d’autore, che resta un genere poco diffuso nell’industria cinematografica. È una missione ammirevole, e assolutamente necessaria.