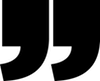Un gruppo di siriani esiliati dal proprio Paese a causa della guerra raccontano le proprie storie davanti a una videocamera.
Filmati sull’isola greca di Lesbo, raccontano la loro esperienza di vita e di perdita, senza possibilità di ritorno; storie di familiari uccisi dai bombardamenti in Siria, richieste assurde imposte dalle forze del Regime e dell’ISIS, che controllano le diverse aree; ci raccontano l’amore per i figli e le figlie che non potranno mai conoscere la bellezza della terra distrutta in cui sono nati.
Questi comuni cittadini parlano con coraggio, umiltà e speranza. Fuggiti da un tormentato conflitto settario, vengono ora chiamati “rifugiati”, e ancora faticano a scappare dalla violenza etnica e religiosa della guerra civile siriana, che imperversa dal 2011, e dalle rivolte della Primavera Araba nei Paesi del Medio Oriente.
In un campo su un’isola battuta dal vento, alcuni siriani affrontano un mare di sofferenze e si mettono davanti a una lente scura per raccontarci dell’altra sponda.
Diretto da Matthew K. Firpo
Produttore esecutivo: Maximilian Guen
Produttori: Matteo Zevi, Haris Katsigiannis, Rosanna Bach, Matthew K. Firpo
Direttore della fotografia: Jake Saner
Montaggio e seconda camera: Stephen Michael Simon
Musica: Shane Carruth
Missaggio: Sean Higgins
Colorazione: Josh Bohoskey, The Mill
Traduzione: Giorgia Frigerio, Michela Maroni, Anna Iaderosa
Intervista

Matthew Kazuo Firpo Regista
“Ci devono essere tanti altri milioni di persone con storie di perdita, dolore e speranza che non sentiremo mai.”
- Com’è nato questo progetto?
Nell’autunno del 2015 avevo appena terminato un lungo progetto commerciale e ci trovavamo nel pieno del ciclo mediatico della crisi dei rifugiati qui negli Stati Uniti. E sentendomi consumato dalle notizie, dai resoconti, dalle foto di disperazione e perdita dal Mar Egeo, mi è venuta voglia di saperne di più sulle persone che vivevano questi titoli di giornale.
Volevo saperne di più sulle loro storie, su quello che avevano perso, su quello che si erano lasciate alle spalle e dove speravano che le loro vite fossero dirette. Mentre i notiziari si concentravano sul problema, spesso si dimenticavano l’essere umano, e quindi il Refuge Project è nato da questo desiderio di saperne di più. Volevo capire la crisi a livello umano e, soprattutto, volevo aiutare. E dando vita a questo progetto, mi sono proposto di aiutare nel modo che conoscevo meglio: attraverso i racconti e la condivisione di storie umane.

- Come si è svolta la produzione?
Siamo partiti da New York il 2 gennaio, dopo alcune intense settimane di pianificazione, ricerche e telefonate internazionali a giornalisti e mediatori che lavoravano in prima linea. Alla fine, tutto si è ridotto a fissare una data e acquistare un volo. Una volta prenotato quel volo, tutto è diventato concreto.
Abbiamo fatto di tutto per procurarci l’attrezzatura che ci serviva, siamo saliti su un aereo e il giorno dopo stavamo facendo riprese in Piazza Vittoria ad Atene. È stata la mia prima volta in Grecia.
Prima di partire avevo parlato a lungo con Matteo Zevi, un amico che alla fine sarebbe diventato uno dei produttori del film, a proposito della realizzazione di un film come questo. Matteo aveva lasciato il suo lavoro qualche mese prima per andare a fare volontariato in Grecia e le sue esperienze hanno plasmato in tanti modi quello che sarebbe diventato il nostro viaggio.
Con un progetto come questo, tutto si riduce alla decisione di dedicarsi a un’idea. Ho scritto un breve trattamento di quello che volevo fare in Grecia, su come volevo aiutare. E poi ho chiesto agli incredibili artisti che mi circondavano se volevano aiutare in un progetto come questo. E hanno risposto di sì.
Tutti hanno offerto tutto a questo progetto – il loro tempo, la loro passione, i loro biglietti aerei – perché credevamo nel potere della narrazione. Ma anche perché sentivamo l’obbligo morale di fare qualcosa per quello che consideravamo una crisi umanitaria.
Sul campo, il progetto è andato avanti alimentato da un misto di fortuna e di “farsi vedere”. Abbiamo seguito ogni possibile pista ed eravamo sempre in movimento. Volevamo catturare storie oneste e volevamo catturare personalmente le esperienze dei rifugiati in movimento per documentare l’atmosfera in prima linea di questa crisi. E questo voleva dire rimanere aperti a tutto, quasi sempre.

- Come avete trovato persone da intervistare e come le avete convinte ad aprirsi con voi sui loro viaggi?
Tutti coloro che abbiamo intervistato nel film li abbiamo incontrati quello stesso giorno.
Il Refuge Project raccoglie solo una manciata molto piccola di storie, prese a caso da una folla di migliaia di persone. E quando si pensa all’enormità di questa crisi, ci si accorge che ci sono tanti altri milioni di storie come queste.
Abbiamo condotto le nostre interviste principalmente in quattro diversi campi profughi in Grecia, lavorando fuori Atene e sulle isole di Lesbo e Lero. Trovare le persone da intervistare consisteva nel processo arbitrario di camminare per ogni campo, parlare con centinaia di persone, chiedere se qualcuno volesse condividere la propria storia finché qualcuno non diceva “sì”. Era davvero così semplice.
E penso spesso, anche ora, a tutte le storie che abbiamo ignorato, alle persone che non ho incontrato o con cui non sono riuscito a parlare e a come, se il nostro film è solo uno spaccato arbitrario di una manciata di campi, ci saranno tanti altri milioni di persone con storie di perdita, dolore e speranza che non sentiremo mai.
Penso che la forza di molte di queste interviste derivi dalla crudezza di queste ferite: per molte delle persone con cui abbiamo parlato, questi eventi erano appena accaduti: la perdita di una persona cara, la distruzione di una casa, il lasciarsi tutto alle spalle. E durante il loro viaggio, poche persone hanno avuto il tempo di elaborare questi sentimenti o esprimere realmente quello che avevano passato. E inoltre, erano circondate da persone che avevano provato la stessa perdita, non erano sole nella loro sofferenza.
Ed è per questo che credo che la condivisione delle storie sia così importante e potente. Più volte siamo rimasti sbalorditi dalla gratitudine delle persone che stavamo intervistando: l’opportunità di parlare semplicemente delle loro storie a voce alta con qualcuno a cui importava qualcosa ha significato molto per loro – questa è stata la loro prima occasione di analizzare il trauma che avevano vissuto.
Credo che anche il modo in cui abbiamo condotto le interviste abbia avuto un ruolo nell’intimità del film concluso. Volevamo separare i soggetti dai loro contesti e concentrarci sugli individui, non sui campi profughi. E nel lavorare con dei traduttori volontari, molti dei quali erano loro stessi rifugiati, la connessione umana è stata fondamentale per me: si trattava di interagire con un volto in una folla, di sedersi con qualcuno e prendersi del tempo per imparare il suo nome, le sue paure, le sue speranze, il perché avesse lasciato la sua casa e cosa sperava di trovare dove stavano andando.
- Una parola su 99 e sulla sottotitolazione multilingue del suo film?
Per me questo progetto ha sempre riguardato la condivisione di queste storie e, in questo modo, la creazione di empatia con un pubblico il più ampio possibile.
99 ha intrapreso una bellissima campagna per condividere film con il mondo. La sottotitolazione del mio film dall’arabo e dall’inglese in una mezza dozzina di lingue apre le porte a un impatto interculturale che ho sempre sognato. L’iniziativa di condividere potenti opere d’arte col mondo è una nobile vocazione, e ho visto il mio film raggiungere nuove persone e portare il suo messaggio di tranquilla dignità sempre più lontano.
Sono grato per l’opportunità di vedere il mio film trasmesso sulla piattaforma.